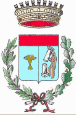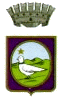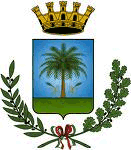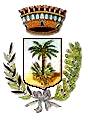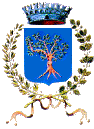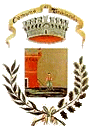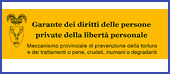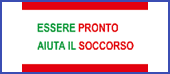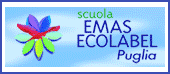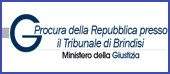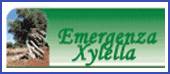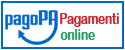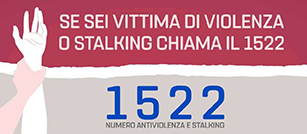Comuni
Comuni
- Dettagli
Dal volume "Viaggio in Terra di Brindisi" di Angela Marinazzo
Continua il viaggio nei Comuni della provincia

Francavilla - Porta del Carmine - Foto coll. Mogavero-Pennetta
Nel 1364 il casale passò a Filippo II d'Angiò, che lo cinse di mura, in seguito ampliate dal principe di Taranto Raimondello del Balzo Orsini. Da costui passò prima ai Borromeo e poi agli Imperiali, che la tennero finché Ferdinando IV di Borbone la dichiarò città libera, alla fine del XVIII secolo. Fu il figlio di Raimondello, il più noto Giovanni Antonio del Balzo Orsini, che fece costruire nel 1455 una grande torre quadrata (primo nucleo di quello che sarebbe diventato il palazzo Imperiali, a pianta rettangolare, che ha la struttura di un castello fortificato), alla quale il marchese di Oria e feudatario di Francavilla Giovanni Bernardino Bonifacio aggiunse - nel 1536 - altre tre torri. I restauri fatti eseguire dagli Imperiali dal 1701 al 1730 lo trasformarono in splendida residenza; ora è la prestigiosa sede dell'Amministrazione comunale. Su una facciata laterale vi è un grande loggiato barocco con quattro arcate incorniciate da sculture; lungo gli altri lati si aprono monòfore rettangolari. Un ampio portale del 700 dà accesso al cortile dov'è il fonte battesimale del XIV secolo che faceva parte della chiesa angioina distrutta dal terremoto del 1743.
Le porte di Francavilla appartengono a secoli diversi: al XVII quella del Carmine, a tre fòrnici, edificata dagli Imperiali nel 1640 più come arco di trionfo che come porta; al XVIII quelle dei Cappuccini e della Croce (1714). Il borgo ha un aspetto rinascimentale e barocco, con i palazzi Pepe, Bottari, Giannuzzi-Carissimo. Alla metà del XVI secolo risalgono i palazzi Cotogno e Argentina. Il palazzo Bianco, in stile rococò, è della fine del XVII secolo.
La chiesa matrice, o chiesa del Rosario, con imponente cupola rivestita da mattonelle di maiolica, fu ricostruita tra il 1743 e il 1759 là dov'era la chiesa angioina della Madonna della Fontana del XIV secolo. In via S. Francesco è la chiesa del Carmine, con annesso convento costruito nel 1517 e utilizzato come ospedale nel 1867. La chiesa di S. Maria della Croce sarebbe stata edificata nella prima metà del sec. XVI là dove esisteva un'antica cappella, dalla quale fu presa un'immagine della Vergine dipinta su muro (databile al XIII secolo), la meglio conservata tra le immagini mariane di tradizione medioevale. Sulla via per Ceglie, fuori la porta dei Cappuccini, è la chiesa dello Spirito Santo, la cui costruzione cominciò il 19 marzo 1759. La chiesa dell'Immacolata fu consacrata dal vescovo di Oria Luigi Margherita il 23 agosto 1869. Nell'agro francavillese, interessanti due cripte basiliane, presso le masserie Caniglia e di S. Croce: l'ultima con affreschi di santi dipinti tra il XV e il XVI secolo.
Importante centro agricolo, artigianale, industriale (piccole e medie imprese) e commerciale, Francavilla è sede della Fiera Nazionale dell'Ascensione, che si svolge nel mese di maggio, giunta nel 2001 alla 62° edizione.
- Dettagli
Dal volume "Viaggio in Terra di Brindisi" di Angela Marinazzo
Continua il viaggio nei Comuni della provincia

Municipio - Foto coll. Pennetta
La zona in cui sorge Fasano dovette apparire a una parte degli abitanti di Egnazia, antica e importante città prima messapica e poi romana, abitata già nell'età del bronzo, XV-XII sec. a. C., distrutta nell'anno 545 dai Goti del re Totila, il luogo ideale in cui stabilirsi per la presenza delle fosse, o fogge, anticamente chiamate pure piscine, pubbliche cisterne in cui si raccoglieva l'acqua piovana, che a loro volta attiravano un gran numero di colombacci, colombi selvatici ambite prede dei cacciatori per le carni pregiate.
Le fogge (dal latino "fovea"), antichissime e profonde, incavate nella pietra, erano scoperte come laghetti e molto vaste, perché non ancora colmate dal terreno trasportato dai torrenti, a seguito della distruzione dei boschi e del dissodamento delle colline. I colombacci erano anche chiamati, volgarmente, "fasi" (dal loro nome greco, poiché erano originari o particolarmente abbondanti nei pressi del fiume Fasi, nella Colchide, Asia Minore), da cui si ritiene che derivi il nome di Fasano, o propriamente Fasciano, ossia terra dei fasi.
Il nome di Fasano si trova per la prima volta in un documento che risale a poco dopo l'anno Mille; mentre lo stemma più antico della città è in un "privilegio" di Carlo V del 1536, e rappresenta un colombaccio in campo azzurro.
Sulla distruzione di Egnazia, importantissimo sito archeologico tra Fasano e Monopoli (città in cui riparò un'altra parte degli Egnatini), è stata formulata l'ipotesi che sia stata in realtà distrutta dai Saraceni tra il IX e il X secolo; ma è possibile che entrambe le ipotesi siano vere, poiché - mentre dell'esistenza del Vescovado di Egnazia si perde traccia dopo la conquista dei Goti - la presenza umana, sia pure in forma precaria, è stata riscontrata nella città distrutta o semidiroccata sino al XIV secolo. Quel che è certo è che la sua fine, con il totale abbandono, non fu determinata tanto dalle distruzioni dei Goti e dei Saraceni (Brindisi, distrutta, fu ricostruita) quanto dal fatto che nel Medioevo il porto, fondamentale per l'economia di Egnazia, e parte della città furono sommersi dal mare per un fenomeno di bradisismo negativo, ossia per un lento movimento della crosta terrestre dal basso verso l'alto. Il sito è ora sede di un Museo Archeologico Nazionale.
All'inizio Fasano fu solo un modesto villaggio intorno a una chiesetta dedicata al culto di S. Maria, dipendente - per concessione del normanno Goffredo, nipote di Roberto il Guiscardo, conte di Conversano, conquistata nel 1054, e "dominatore" di Monopoli, ove dimorava - dalla badia (o monastero) benedettina di S. Stefano, presso Monopoli. Fasano era allora indicato come "casale in costruzione". Un altro convento, dedicato a S. Giovanni, era proprio a Fasano, a Sud-Est delle fogge. Tra l'VIII e il X secolo sorsero gli insediamenti monastici, con chiese e villaggi rupestri abitati anche da contadini, di Lama d'Antico, S. Lorenzo, S. Giovanni e Lamalunga. L'insediamento di Lama d'Antico, in particolare, è uno dei più importanti della Puglia.
Nel 1317, papa Giovanni XXII tolse S. Stefano ai Benedettini e concesse il convento con tutte le terre, incluso il casale di Fasano, e i diritti annessi all'Ordine militare religioso degli Ospitalieri, detti anche Cavalieri Gerosolimitani (poi di Rodi, e infine di Malta), che costruirono la prima chiesa matrice. Dedicata a S. Giovanni Battista, fu ampliata e rinnovata nel 1594, aperta al culto nel 1600 e in pratica rifatta nel 1787.
Nella seconda metà del XVI secolo Fasano ebbe un rapidissimo sviluppo, perché assorbì tutta la popolazione sparsa tra il mare e le colline, tra Ostuni e Monopoli. Risale al 2 giugno 1678 l'avvenimento storico più memorabile di Fasano. Nei pressi di Torre Canne sbarcarono 400 Turchi: 100 rimasero a guardia delle imbarcazioni e 300 penetrarono in Fasano nella parte sfornita di mura. I cittadini si difesero bene, i Turchi finsero di fuggire, i Fasanesi li inseguirono e sulla spiaggia lottarono a corpo a corpo per un'ora, finché gli invasori furono costretti alla fuga.
Un altro episodio degno di nota è il rinvenimento in una grotta, in contrada Pozzo Faceto, dell'immagine della Madonna, per merito di alcuni contadini che stavano scavando un pozzo: da questo nacquero il santuario e la frazione.
Il territorio di Fasano è il più ricco di frazioni: Pezze di Greco, la più popolosa, Speziale, Montalbano, Savelletri, le più importanti. Numerose le masserie (dal latino "massa", nel senso di proprietà agricola): aziende organizzate e autonome, perché producevano, trasformavano e commerciavano i prodotti agricoli e zootecnici, ed in grado di difendersi prima dai pirati e poi dai briganti. Quelle esistenti nella provincia si possono collocare tra il 500 e il 700. Persero la loro funzione con l'abolizione della feudalità (1806) e l'esproprio dei beni degli enti ecclesiastici del 1866.
Sulla costa è la masseria Seppannibale grande, al cui interno è un tempietto indicato in una bolla del 1180 col nome di S. Pietro Veterano: le sue pareti erano un tempo completamente affrescate. Tra le masserie fortificate, notevole è la masseria Ottava grande, in cui è inserita la chiesa di S. Pietro "de Octava". Del tipo a torre fortificata con quattro bastioni angolari di forma trapezoidale, caditoie e garitte è l'imponente masseria Pettolecchia, in un bosco di ulivi secolari. Nella lama della masseria signora Cecca esiste ancor oggi un villaggio medievale abbandonato.
Fasano è dominata dalla collina della Selva (oltre che di Laureto), dai bellissimi panorami sulla campagna e sul mare; ha un bel porto come Savelletri, una stazione termale come Torre Canne, un sito archeologico come Egnazia: quanto di meglio si possa desiderare per un centro turistico di grandissima importanza, qual è da tempo, non solo per la provincia ma per l'intera regione.
- Dettagli
Dal volume "Viaggio in Terra di Brindisi" di Angela Marinazzo
Continua il viaggio nei Comuni della provincia

Palazzo ducale
Foto Mogavero - Pennetta
Nel XVII secolo, Erchie entrò a far parte - come altri paesi vicini - del feudo degli Imperiali che, per ripopolarla, concessero le sue terre ai profughi di Candia, l'antico nome dell'isola di Creta oltreché della città di Heraklion, allorché la loro isola passò dalla dominazione veneziana a quella turca.
Il palazzo ducale risale agli ultimi decenni del 700 e si ritiene che sia stato disegnato dal grande architetto neoclassico di Oria Francesco Milizia (1725-1798), che fu anche uno storico dell'architettura.
- Dettagli
Dal volume "Viaggio in Terra di Brindisi" di Angela Marinazzo
Continua il viaggio nei Comuni della provincia

Borgo antico - Foto coll. Mogavero-Pennetta
Il territorio di Cisternino era già abitato nella preistoria, dal paleolitico al neolitico, e i reperti della loro vita dedicata alla caccia e alla raccolta sono conservati nel Museo Civico. Numerosi erano anche gli insediamenti nell'età del bronzo. I primi agglomerati urbani sorsero nelle zone di San Salvatore, Gianecchia e Calabrese.
Il nome deriverebbe da "Cis-Sturninum", al di qua di Sturni, antico centro japigio nei pressi di Ostuni che aveva preso la denominazione da Sturno, compagno dell'eroe omerico Diomede, scampati alla guerra di Troia. Partecipò alla lega messapica contro Taranto. Fu conquistata dai Romani che, per la salubrità dei luoghi, vi costruirono ville rustiche. Fu probabilmente sul sito di una di queste che i monaci basiliani costruirono nell'VIII secolo la badia di S. Nicola di Pàtara. Sulle fondazioni della chiesa bizantina fu edificata nel XIV secolo, in stile romanico pugliese, la chiesa matrice intitolata a S. Nicola, che conserva una scultura in pietra locale del 1517 raffigurante la Madonna del Cardellino, dello scultore Stefano da Putignano, un coro del XVII secolo e un crocifisso di legno del 300. Nell'adiacente casa canonica sono una scultura di legno raffigurante la Madonna della Madia, e una tela del XVIII secolo nella quale, ai piedi dei Santi Quirico e Giuditta, patroni della città, è una veduta prospettica della città. Nella stessa piazza dov'è la chiesa matrice, è la torre Normanno-Sveva del XIII secolo, che anticamente costituiva la porta di accesso al casale.
E' stata feudo dei Vescovi e dei signori di Monopoli fino al 1505, quando fu conquistata dai Veneziani, che la detennero fino all'arrivo degli Spagnoli, la cui oppressione fiscale fece insorgere i cittadini. Tra le altre chiese, quelle barocche di S. Quirico, di S. Cataldo e del cimitero vecchio, con affreschi del 1600. Fuori dell'abitato, in contrada Lamacesare, è la piccola chiesa romanica di S. Maria di Bernis.
Le abitazioni del borgo antico, imbiancate a calce, sono rimaste pressoché intatte dal 400 in poi, con le torri e parte delle mura; vi sono anche palazzi del 700 con ampi portali e giardini pensili.

Trullo sovrano - - Foto coll. Mogavero-Pennetta
Dal "belvedere" si ha lo stupendo panorama della Valle d'Itria, ricca di ulivi e mandorli, o valle dei trulli (dal greco tardo trullos = cupola), per queste caratteristiche costruzioni a pianta generalmente circolare all'esterno, quadrata all'interno, su cui si imposta la cupola aggettante a tholos (derivata dalla civiltà micenea), ottenuta con pietre calcaree piatte. La più antica testimonianza della presenza di trulli in Puglia è in una pergamena del 917. Opera di bravi maestri muratori, i trulli avevano in origine funzione di ricovero per il bestiame, o di deposito per gli attrezzi agricoli, ma anche di riparo per i contadini. A questa funzione si collegava, come per i muretti a secco, l'esigenza di liberare il terreno agricolo dal gran numero di pietre che ostacolavano le colture o il pascolo. Il "trullo sovrano" ha un vano superiore a quello destinato ad abitazione, che è adibito a magazzino.
- Dettagli
Dal volume "Viaggio in Terra di Brindisi" di Angela Marinazzo
Continua il viaggio nei Comuni della provincia

Chiesa di San Marco - Foto coll. Pennetta
Anche il territorio di Cellino sarebbe stato abitato in tempi molto antichi, come dimostrano le stazioni preistoriche rinvenute. Il casale, attuale Comune, risalirebbe invece al IX o X secolo, allorché i monaci basiliani vi stabilirono una grancia (deposito di grano), poi facente parte dei possedimenti dei benedettini dell'abbazia di S. Andrea dell'Isola di Brindisi. L'origine del nome è chiara: deriva dall'albero di ulivo che caratterizzava l'agro cellinese, chiamato "celino", da cui l'oliva "celina" o "cellina", nerissima nella piena maturità (così detta dal termine greco che indicava il colore nero), una qualità in grado di dare un olio dolce e fino; denominata anche "saracenica", perché sarebbe stata importata dai Saraceni.
Solo un secolo fa l'economia agricola di Cellino, come quella dei Comuni vicini, fu convertita a vigneto. La vite è, con l'ulivo e il mandorlo, una delle piante d'importazione greca che non temono la siccità, poiché nel Salento - in contrasto con la fitta rete delle acque sotterranee, che raggiungono anche i 400 metri di profondità, in cui svaniscono le piogge subito assorbite - la crosta terrestre, costituita in gran parte da calcari cretacei e priva com'è di corsi d'acqua superficiali, è asciutta.
Lo stemma, approvato nel 1929 ma risalente al 1822, mostra un ulivo su fondo colore argento, con le lettere C ed L ai due lati. Nel 1862 furono aggiunte al nome le parole "San Marco", per distinguerlo dal Comune di Cellino Attanasio ch'è in provincia di Teramo. La particolare devozione per l'Evangelista Marco potrebbe derivare dal fatto che il Salento è stato un importante avamposto della Repubblica di Venezia, per lungo tempo la maggiore potenza commerciale del Mediterraneo.
Un castello dal torrione quadrato, che ha subito nei secoli numerose modifiche e aggiunte, fu costruito - probabilmente nel 1578 - da Antonio Albrizzi; divenne in seguito proprietà dei Chyurlia (nel 1756 ne risultavano già proprietari), conti di Cellino, che lo ampliarono per trasformarlo in loro residenza. La cappella dedicata a San Marco (ora chiesa del cimitero), che ha sull'altare maggiore una tela raffigurante l'Evangelista, fu costruita nel 1716 - in occasione del ripopolamento del territorio, prima ricoperto da una parte dell'antica foresta oritana - sullo stesso luogo in cui era una cappella basiliana del IX secolo. Pure la chiesa matrice, dedicata a Santa Caterina d'Alessandria, nel cui interno sono altari barocchi e tele del sec. XVIII, fu costruita nel 1870 circa là dov'era una precedente chiesa edificata nel 1738 e più volte restaurata.
- Dettagli
Dal volume "Viaggio in Terra di Brindisi" di Angela Marinazzo
Continua il viaggio nei Comuni della provincia

Torre dell'orologio - Foto coll. Mogavero-Pennetta
Importante centro militare, politico e religioso dell'antico Stato dei Messapi (Caelium ricordato da Plinio), fu fiorente soprattutto nel IV-III sec. a. C., e sono tuttora visibili tratti della cerchia muraria, il Paretone, che doveva racchiudere l'abitato messapico. Fu a capo delle altre città della Messapia contro Taranto, uscendone dapprima vittoriosa, ma poi fu espugnata e completamente distrutta dai Tarantini, che nella battaglia uccisero il re Opis che guidava l'esercito e che si ritiene abitasse nella roccaforte cegliese. Si vuole pure che a Ceglie avessero sede i più importanti edifici di culto dei Messapi e dei Romani; ipotesi confermata dal rinvenimento nell'abitato di tombe con ricche suppellettili e numerose iscrizioni messapiche (conservate nella pinacoteca comunale).
Con la caduta dell'Impero romano d'Occidente, Ceglie fu devastata dai Goti, Longobardi e Visigoti. Divenuta feudo degli Angioini, fu concessa in dote da Carlo II d'Angiò a sua figlia Eleonora, che andò in sposa al barone Filippo di Tuzziaco. Divenuta feudo della Curia Arcivescovile di Brindisi, fu venduta intorno alla metà del XIV secolo ai duchi di Sanseverino, dai quali passò ai Luperano e da questi ai Sisto-Britto. Durante il Risorgimento furono aperte a Ceglie numerose "vendite" carbonare e sezioni della Giovine Italia.
Nel centro del borgo medievale è il castello, le cui strutture più antiche risalgono probabilmente all'XI secolo. Sul torrione cilindrico domina una torre quadrata la cui costruzione, voluta dal duca Fabrizio Sanseverino, risale al 1492; mentre il palazzo è di pochi anni più tardi (1525). L'ultima proprietaria è stata la famiglia Verusio. Nei suoi pressi è la chiesa matrice, più volte rimaneggiata, che ha assunto l'attuale aspetto barocco nel 1796. All'interno si conservano un pregevole crocefisso di legno e un Cristo a mezzo busto scolpito nella pietra. Al centro storico si accede dalle porte di Giuso, con tracce dell'originale architettura gotica, e Monterone, quest'ultima difesa da una torre quadrata del XV secolo.
Sulla via per Francavilla sono la chiesetta della Madonna della Grotta, nella cui cripta basiliana sono visibili affreschi del XIII secolo, e la grotta carsica di contrada S. Michele, in cui è un affresco più antico, risalente probabilmente al sec. VIII (il più antico della provincia), che raffigura la Madonna orante. La vita contadina è documentata nel Museo della Civiltà del Trullo, che ha sede in un complesso di trulli risalenti al 1792, nella masseria Montedoro.
Spettacolari le grotte di Montevicoli, con stalagmiti e stalattiti, che a Natale diventano la sede splendida per il Presepe vivente. Al loro interno sono state rinvenute iscrizioni messapiche con dedica alla dea Afrodite, alla quale doveva essere stato dedicato un tempio; mentre un tempio ad Apollo doveva trovarsi sul luogo ove sorge la chiesa di S. Rocco.
Nell'agro cegliese sono le "specchie" (la più antica è quella Miano, o di Castelluzzo), i principali documenti - rimasti pressoché intatti - della civiltà messapica: torri di avvistamento e monumenti a tronco di cono con scale esterne a rampa o a gradoni che li cingono a spirali tutto intorno. Nella struttura ricordano le tombe circolari dell'antica Creta, ma potrebbero essere state, con molta probabilità, torri di vedetta e di difesa, data anche la derivazione del loro nome dal latino "specula", ossia posti di osservazione.
- Dettagli
Dal volume "Viaggio in Terra di Brindisi" di Angela Marinazzo
Continua il viaggio nei Comuni della provincia

Castello - Foto coll. Pennetta
La chiesa matrice, che è dedicata all'Assunta, fu ricostruita nei primi dell'800 sulla struttura di un'antica chiesa edificata tra la fine del 1400 e l'inizio del 1500. Della vecchia fabbrica conserva, sulla facciata, un pregevole rosone e un frammento del portale con angelo in rilievo.
Di notevole interesse anche la storia del borgo di Serranova, che si trova a sei chilometri da Carovigno, verso il mare. Il nobile Ottavio Serra fece costruire nel 1629 un castello incorporando un torrione quadrangolare del XIV secolo. Le abitazioni sorte intorno costituirono il casale di Serranova. Addossata al castello è la chiesetta del Crocefisso, in cui è conservato un crocefisso in legno del 1700, cui i Carovignesi sono sempre stati molto devoti perché lo ritenevano giunto dal mare, a seguito di un naufragio. A quattro chilometri dall'abitato è il Santuario di S. Maria di Belvedere: dalla chiesa si scende in due ampie grotte comunicanti, e in una è l'edicola con l'affresco della Madonna col Bambino del sec. XIV.
A sette chilometri da Carovigno, sulla costa, è Santa Sabina, con una torre di forma stellare, che fu approdo della Carbina messapica sin dal VII sec. a. C., come testimoniano i frammenti ceramici rinvenuti sui suoi fondali; oggi è rinomato villaggio turistico. Il nome deriva molto probabilmente dalla santa venerata in una delle cripte rupestri del territorio, nei cui pressi era un villaggio preistorico, e dal rinvenimento in mare di una statuetta che la raffigura.
 Tessitrice - Foto coll. Mogavero-Pennetta
Tessitrice - Foto coll. Mogavero-PennettaUna peculiarità importante dell'economia di Carovigno è stata l'artigianato tessile, anche in tempi recenti, ad opera di donne che lavoravano al telaio (la "tessitrice" è uno dei personaggi che simboleggiano le attività della terra di Brindisi, nella grande tela del salone di rappresentanza della Provincia, dipinta nel 1949 da Mario Prayer); ma vi sono ancora donne che lavorano completamente a mano tappeti, arazzi, coperte, tovaglie, impreziosite con decorazioni secondo tecniche tramandate da secoli.
- Dettagli
 Colonne terminali della "Via Appia" - Foto coll. Mogavero-Pennetta
Colonne terminali della "Via Appia" - Foto coll. Mogavero-Pennetta
Dalla preistoria ai Messapi e ai Romani
Le testimonianze più antiche rinvenute nel territorio del Comune risalgono al paleolitico (età della pietra antica), e sono conservate nel Museo Archeologico Provinciale intitolato a Francesco Ribezzo, di Francavilla Fontana, archeologo e glottologo insigne (1875-1952). I reperti più abbondanti provengono da un villaggio dell'età del bronzo media (XVI sec. a. C.), scoperto a Punta le Terrare, che si trova a sud del porto medio di Brindisi: un terrapieno di pietre eretto a difesa di un gruppo di capanne, nelle quali sono stati trovati pure frammenti di ceramica micenea, a conferma delle affermazioni di Erodoto e degli stretti rapporti da sempre intercorsi con il mondo greco. Del periodo messapico (VII-III sec. a. C.) sono conservate al Museo le "trozzelle": le anfore per acqua caratterizzate da alte anse verticali che terminano spesso con quattro o più rotelle, a forma di carrucola, dalla cui voce latina 'trochlea' deriva il loro nome. Resti delle mura megalitiche dei Messapi si trovano in via Camassa e corte Capozziello e in un'abitazione privata di via Montenegro.
Moltissime sono le testimonianze di epoca romana (dal III sec. a. C. al IV d. C.), conservate sia nelle aree archeologiche di San Pietro degli Schiavoni (sotto il teatro sospeso), di via Casimiro, della piazzetta Virgilio, dov'erano le "colonne romane" (III sec. d. C., a giudicare dal capitello), e nei pressi di Porta Mesagne, ove sono i resti delle vasche per la decantazione delle acque provenienti dal pozzo di Vito; sia al Museo, che espone sculture in marmo e in bronzo, epigrafi e molte monete, tra cui quelle di bronzo del III sec. a. C. che hanno sul diritto la testa di Nettuno, e sul rovescio Falanto che cavalca un delfino e la scritta BRVN. Anticamente, tutte le città cercavano di far risalire le loro origini a un dio, e i primi abitanti di Brindisi diffusero la leggenda che il nome della città derivava dal nome del figlio di Ercole, Brento, che ne sarebbe stato il fondatore. Più concretamente, i geografi e gli storici greci e latini fanno derivare il nome Brun o Brunda dalla parola messapica che significava "testa di cervo", cui la forma del porto somiglia. Ma "brun" era anche la voce onomatopeica con cui s'indicava l'acqua, che circonda quasi completamente la città.

Porta Mesagne (detta anche Porta Napoli) - Foto coll. Nolasco
Dopo i Romani
Con l'Impero romano d'occidente, decaddero anche il porto e la città di Brindisi. Si ripresero, dopo alterne vicende, solo con i Normanni, cui si devono la prima fabbrica romanica della Cattedrale (1132), la chiesa di San Benedetto (di poco precedente al 1089) e il piccolo tempio di S. Giovanni al Sepolcro (inizi del XII secolo); con gli Svevi e Federico II, che fece costruire nel 1227, con il materiale ottenuto dalla demolizione dell'anfiteatro romano, il primo nucleo del Castello di terra; con gli Angioini, che per motivi militari resero di nuovo il porto praticabile alle grandi flotte, e gli Aragonesi, che fortificarono la città e fecero edificare nel 1481 il Castello Alfonsino. Ma 31 anni prima, nel 1450, il principe di Taranto Giovanni Antonio Orsini del Balzo aveva fatto interrare nuovamente il canale per impedire ai Veneziani di impadronirsi di Brindisi (provocando così la malaria e l'elevata mortalità degli abitanti); e sei anni dopo un terremoto aveva quasi spopolato la città. Furono proprio i Veneziani, dal 1496, a far rifiorire l'economia brindisina, con la costruzione di cantieri navali e la ripresa dei traffici mercantili; ma il loro dominio durò solo 13 anni.
Il porto interno divenne nuovamente una palude con gli Spagnoli e i Borboni, e la malaria rese Brindisi pressoché inabitabile. I lavori per la riapertura del canale - il cui ruolo, come si è visto, è stato decisivo nella storia della città negli ultimi duemila anni - furono eseguiti in tre riprese: i primi, dal marzo 1776 al novembre 1778, a cura dell'ing. Andrea Pigonati, che non riuscirono però ad evitare un nuovo interramento; i secondi nel 1789, a cura degli ingg. Pollio e Forte, che non apportarono benefici di lunga durata; e gli ultimi, dal 1843 al 1847, affidati da Ferdinando II di Borbone al col. del Genio Albino Mayro, il quale, tenendo conto dei venti predominanti, orientò in modo diverso il canale (verso tramontana e non verso greco-levante, come aveva voluto Pigonati).
Le chiese

(coll. Nolasco)
I palazzi

Palazzo Granafei-Nervegna
(coll. Nolasco)
Il palazzo arcivescovile (già Seminario), del 1720, probabile opera dell'arch. Manieri, è il più importante monumento barocco della città; la facciata è decorata da otto statue che raffigurano l'Armonia, l'Etica, la Filosofia, la Giurisprudenza, la Matematica, l'Oratoria, la Poetica, la Teologia. La parte più antica si affaccia su vico Guerrieri: lungo il suo prospetto sono visibili gli archi ad ogiva e le merlature in rilievo. Nel cortile interno si affaccia la torre quadrangolare dell'Episcopio. La loggia Balsamo, che risale alla prima metà del XIV secolo, faceva probabilmente parte della zecca angioina. E' caratterizzata da mensole a gradoni con bizzarre figure d'uomini e animali, unite da archetti superiori. Nel palazzo Granafei-Nervegna, del XVI secolo, si fondono elementi rinascimentali e soluzioni barocche e manieriste. Eretto dalla famiglia Granafei, fu poi abitato dai Nervegna, l'ultimo dei quali fu un noto numismatico. Un'iscrizione latina, posta sulla facciata, dice fra l'altro "Il saggio costruisce la casa mentre lo stolto la distrugge" e "A che servono allo stolto le ricchezze dal momento che non può comprare la saggezza ? "
All'interno del palazzo Montenegro, del XVII secolo, di proprietà della Provincia, con grande balcone sostenuto da mensole decorate, fu rinvenuta un'iscrizione marmorea dedicata all'imperatore Traiano. Di un secolo dopo è il palazzo Perez, con ampio portale architravato; mentre il vicino e più antico palazzo degli Scolmafora, devastato da un incendio, fu ricostruito nel 1652.
In via Carmine è il palazzo Ripa, del sec. XVII, con ricco portale sormontato dallo stemma della famiglia Ripa, che ha urgente bisogno di essere restaurato e riutilizzato: una sede ideale per un museo di storia moderna e delle tradizioni locali.