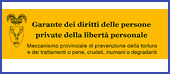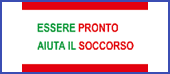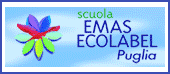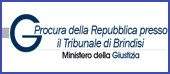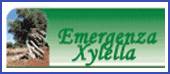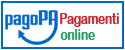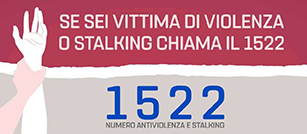Comuni
Comuni
- Dettagli
Dal volume "Viaggio in Terra di Brindisi" di Angela Marinazzo
Continua il viaggio nei Comuni della provincia

Villa Castelli - Municipio - Foto coll. Mogavero-Pennetta
Un bene ambientale interessante è la "gravina" (grande burrone), tornata all'antico splendore con la messa a dimora di piante ed essenze mediterranee. Sulla via per Francavilla è la chiesetta della Madonna dei Grani, edificata su una grancia (fabbricato rurale con funzione di deposito) basiliana del XII secolo. Nell'agro di Villa Castelli è pure interessante l'insediamento di Pezza Petrosa, frequentato dalla fine del V al III sec. a. C.
- Dettagli
Dal volume "Viaggio in Terra di Brindisi" di Angela Marinazzo
Continua il viaggio nei Comuni della provincia

Castello - Foto coll. Pennetta
A circa quattro km, sulla strada provinciale per Mesagne, nella masseria "Le Torri" (per inciso, l'origine della masseria sarebbe longobarda e il nome deriverebbe dal celtico mas campagna, più er abitazione) vi è la chiesa bizantina di S. Maria di Crepacore, costruita probabilmente prima del IX secolo. Il casale di Crepacore fu abbandonato agli inizi del XIV secolo, allorché cominciò a prendere forma o a svilupparsi, con gli abitanti dei casali vicini, il paese di Torre intorno al nucleo fortificato costituito dalla "turris Messapiorum". Nella chiesa, come in quella che fu dedicata a Oria ai santi Crisanto e Daria, vi è un'altra esemplificazione del "trullo", poiché il suo impianto quadrato, costruito con conci di càrparo delle dimensioni di cm 150 x cm 70 ricavati da costruzioni preromane della zona, è coperto da due cupole.
Nel 1281 Carlo I d'Angiò fece costruire una torre chiamata "Osanna", che - semidistrutta dai terremoti del 1627 e del 1743 - fu abbattuta nel 1823; al suo posto, nel 1837 fu eretta la colonna con la statua di Santa Susanna. La costruzione del castello - su un preesistente nucleo medievale - ebbe inizio nel 1588 e termine nel 1595. I merli sulla sommità furono fatti aggiungere nel secolo successivo dai conti Filo di Napoli che, divenuti feudatari del paese, trasformarono il castello in loro residenza.
La Chiesa Matrice, dedicata prima alla Vergine, poi a San Nicola e infine a Santa Susanna, sarebbe stata edificata a una navata già nel 1330; lavori di ristrutturazione, eseguiti nel 1581, interessarono soprattutto la facciata, che ha un grande rosone centrale, mentre il portale fu fatto eseguire nel 1599; altri lavori, che durarono dal 1774 al 1782, portarono le navate a tre. All'interno è il ritratto di San Carlo Borromeo, del XVII secolo, del pittore ateniese Giovanni Papageorgio. La Chiesa di S. Maria di Galaso fu costruita nel sec. XV là dov'era un'antica cappella, tredici gradini sotto il livello stradale. Sull'altare maggiore è l'immagine della Madonna col Bambino, miracolosamente estratta da un pozzo cui si accede dalla parte posteriore dello stesso altare. Dal 1949 la Chiesa è santuario mariano della diocesi di Oria.
- Dettagli
Dal volume "Viaggio in Terra di Brindisi" di Angela Marinazzo
Continua il viaggio nei Comuni della provincia

Casa fortificata (sec. XV) - Foto coll. Pennetta
Come San Pietro Vernotico, deve il suo sviluppo ai profughi di Valesio (distrutta nel 1157 da Guglielmo I d'Altavilla, che tre anni prima era divenuto re di Puglia e di Sicilia), i cui resti archeologici si trovano in agro di Torchiarolo.
La torre, il cui primo nucleo fu costruito nel XVI secolo a scopo difensivo dalle frequenti (a causa della vicinanza della costa) incursioni dei pirati e dei Turchi, è stata ampliata nei due secoli successivi per essere adattata a palazzo baronale: il territorio è stato infatti feudo della contea di Lecce. La casa fortificata di S. Domenico, della fine del sec. XVI, è l'unica costruzione di questo tipo rimasta nella provincia: bassa e dotata anch'essa di sistemi difensivi è al centro di una corte recintata da un alto e spesso muro, con l'unico ingresso ad arco sovrastato da una caditoia; in pratica un fortino, in grado evidentemente di respingere con successo gli attaccanti.
La chiesa matrice, del sec. XVIII e a tre navate, è dedicata a Maria SS. Assunta; lo stemma inserito nella facciata raffigura un turco in catene; all'interno è la statua della Madonna di Galliano (o Galeano), parola di origine longobarda che significa "della Selva o della Foresta". A Lei è intitolato il santuario ricostruito dov'era una chiesetta dell'VIII o IX secolo, in cui sono l'affresco medievale della Madonna e una parte dell'abside del tempio originario. Nelle campagne vi sono cappelle rurali, annesse o prossime alle masserie, oltre ad edicole votive, che denotano la spiccata religiosità degli abitanti.
Valesio, dai Torchiarolesi chiamata "Valisu" come la zona in cui si trovano i suoi resti, fu un importante centro prima messapico (le ceramiche più antiche rinvenute risalgono alla prima metà dell'VIII sec. a. C.) e poi romano. Dopo Egnazia è la più importante area archeologica della provincia. All'inizio dell'epoca imperiale romana la città venne chiamata Aletia dal geografo greco Strabone; gli scrittori latini la chiamavano Valetium o Balesium; nel IV secolo, nella famosa carta stradale "Tabula Peutingeriana", venne indicata come Balentium; nel 1100, poco prima della sua distruzione, Valentium. Antonio de Ferrariis, detto il Galateo dalla città d'origine (Galàtone), che nel 1511 abitava presso Trepuzzi, scrisse: "Sulla strada campestre che va da Brindisi a Lecce è situata Balesus, che è andata completamente distrutta". Era attraversata dalla via Traiana-Càlabra e da un torrente. Al tempo di Costantino I il Grande (280-337), Valesio divenne stazione viaria del servizio postale imperiale: situata com'è a metà distanza tra Brindisi e Lecce, fu sede di mutatio (posto di cambio di cavalli o di muli) e fornita di servizi tra i quali un complesso termale. Nell'ultimo tratto della via Traiana, solo Brindisi, Lecce e Otranto erano fornite di alberghi (mansiones), e la distanza tra Brindisi e Otranto era coperta in due giornate: i viaggiatori passavano una notte a Lecce (Lupiae), mentre le cavalcature venivano cambiate alla mutatio Valentia (Valesio) e alla mutatio Ad duodecimum, a metà strada tra Lecce e Otranto.
- Dettagli
Dal volume "Viaggio in Terra di Brindisi" di Angela Marinazzo
Continua il viaggio nei Comuni della provincia

Castello
Foto Mogavero - Pennetta
Sarebbe stata fondata nell'XI secolo quando il normanno Boemondo d'Altavilla, figlio di Roberto il Guiscardo e principe di Taranto, fece edificare quale padiglione di caccia una torre quadrata, tuttora esistente. I primi abitanti sarebbero stati gli Schiavoni (accrescitivo di schiavo, ma nel senso di "slavo"), come ricorda l'antico nome della città, giunti mille anni fa dall'opposta sponda dell'Adriatico (per inciso, Schiavoni furono dal XVII secolo anche le guardie del doge di Venezia). Ma l'origine di San Vito, così chiamata per la devozione degli abitanti al santo, potrebbe però essere molto più antica, poiché fra le contrade Castello e Paretone sono stati rinvenuti reperti preistorici e tombe messapiche e romane. E' stata feudo dei Sambiasi, del Balzo Orsini (che nel XV secolo avrebbero costruito il castello incorporandovi l'antica torre normanna), Serra, Dentice di Frasso (attuali proprietari del castello, che hanno adattato a propria residenza, dopo i numerosi ampliamenti e ristrutturazioni di cui è stato fatto oggetto in oltre cinque secoli).
 Chiesa di San Giovanni
Chiesa di San GiovanniFoto coll. Mogavero-Pennetta
- Dettagli
Dal volume "Viaggio in Terra di Brindisi" di Angela Marinazzo
Continua il viaggio nei Comuni della provincia

Chiesa Matrice - Foto coll. Pennetta
Sarebbe sorta poco prima dell'abbandono di Valesio, il centro messapico distrutto nel 1157 da Guglielmo I d'Altavilla, re di Sicilia, detto il Malo. Una parte dei superstiti si rifugiarono attorno a una grancia basiliana, forse già intitolata all'Apostolo Pietro, determinando la nascita e lo sviluppo del casale. La denominazione di San Pietro Vernotico, in cui quest'ultimo termine potrebbe derivare - ma è solo un'ipotesi - dal latino vernaculum, nel senso traslato di "locale, del paese" (San Pietro nostro), in un'epoca in cui erano molti i centri che si mettevano sotto la protezione del principe degli Apostoli, appare in documenti ufficiali del 500. Per inciso, sono ben 33 i Comuni italiani che attualmente hanno le parole "San Pietro" nel loro nome. E' meno probabile che derivi da vernalis (primaverile), com'è stato supposto. Il suo stemma rappresenta una quercia, simbolo di forza, su fondo azzurro.
Al centro del paese è la torre a pianta quadrangolare, con merlature e caditoie e volte a crociera, costruita nel XVI secolo per difendere il paese dalle incursioni dei Turchi, e più volte restaurata per divenire la sede della signoria dei vescovi di Lecce, della cui mensa (nel significato di "rendita"), il feudo faceva parte dal XII secolo. E' al 1480, anno della presa d'Otranto, o poco più tardi, che si riferisce l'episodio che ha ispirato l'"Asta della Bandiera", la manifestazione che si tiene a San Pietro ogni anno, nel giorno di Pasqua: un combattimento vittorioso oppose i Sampietrani ai Turchi che cercavano di saccheggiare il paese, in occasione del quale il nemico fu costretto ad abbandonare la sua insegna.
La chiesa matrice è dedicata a Maria SS. Assunta e ha un elegante rosone con vetrata dipinta con l'immagine della Madonna; nel XIX secolo all'originaria navata unica ne furono aggiunte altre due laterali. La secentesca chiesa di San Pietro, costruita probabilmente sulla base di un preesistente tempio medievale, ha ricchi altari barocchi e tele del 600, tra cui una raffigurante l'Apostolo Pietro; fu restaurata con il rifacimento del frontespizio nel 1794, mentre il campanile a vela è del 1936.
- Dettagli
Dal volume "Viaggio in Terra di Brindisi" di Angela Marinazzo
Continua il viaggio nei Comuni della provincia

Cattedrale - Foto coll. Pennetta
Tra San Pancrazio e Mesagne è la zona archeologica di Muro Maurizio, con tracce di una possente cerchia muraria, in cui da secoli si rinvengono epigrafi messapiche e monete greche e romane; scavi recenti hanno confermato che il territorio comunale era già abitato in epoca messapica. Il casale di San Pancrazio sorse un migliaio di anni fa, intorno alla chiesa dedicata al Santo protettore; nel XII secolo era diventato feudo degli Arcivescovi di Brindisi, della cui mensa (nel significato di rendita) fece parte sino al 1866, allorché i suoi beni passarono allo Stato. Fu l'Arcivescovo (poi cardinale) Girolamo Aleandro, che resse la sede brindisina dal 20 dicembre 1524, ad eleggere San Pancrazio - per la bontà dell'aria - sua residenza estiva, utilizzando il palazzo fatto costruire dai suoi predecessori. Lo stemma comunale, riconosciuto nel 1931, mostra un'aquila coronata ad ali spiegate, che ha nel becco una spiga di grano e una stella sul petto. Frazione di Torre, divenne Comune dal 1° gennaio 1839. Nel 1862 aggiunse al nome l'aggettivo "Salentino", ad evitare confusioni con altro Comune italiano avente lo stesso nome; un'esigenza nata per molti Comuni italiani con l'unificazione del Paese.

Chiesa di S. Antonio. Affreschi - Foto coll. Pennetta
- Dettagli
Dal volume "Viaggio in Terra di Brindisi" di Angela Marinazzo
Continua il viaggio nei Comuni della provincia

San Michele Salentino - Chiesa Vecchia
Foto coll. Mogavero-Pennetta
Frazione di San Vito fino al 1928, allorché ottenne l'autonomia comunale, nacque ai primi del 900 per volontà del principe di San Vito Michele Dentice di Frasso, che concesse in enfitèusi ai contadini sanvitesi, oltre che di Ostuni e Francavilla, perché vi abitassero stabilmente, i terreni facenti parte del piccolo casale di Masseria Nuova. Cambiò il nome in San Michele, in onore dell'Arcangelo riconosciuto protettore della cittadina; con l'aggiunta di "Salentino" per distinguerlo dagli altri Comuni italiani con lo stesso nome.
Lo stemma rappresenta San Michele con la spada e, al suo fianco, una torre merlata. La Chiesa Matrice è del 1937. Nell'agro è il Santuario di San Giacomo edificato nel XIX secolo su una cripta basiliana, in cui si conserva un affresco raffigurante la Madonna col Bambino. Un Comune con una storia così breve ha il grande merito di avere una pinacoteca, sorta per iniziativa del cittadino Stefano Cavallo, con opere di Manzù, De Chirico ed altri.
- Dettagli
Dal volume "Viaggio in Terra di Brindisi" di Angela Marinazzo
Continua il viaggio nei Comuni della provincia

Tempio di San Miserino - Foto coll. Pennetta
Il suo territorio fu abitato dai Messapi; ma il casale dovette esistere già ai tempi dei Romani, come si rileverebbe dall'impianto urbano e dai resti di ville prediali romane nei pressi. Come San Pancrazio, fu feudo degli Arcivescovi di Brindisi, cui fu donato dal re normanno Tancredi nel 1130. Il suo nome, documentato già nel sec. XII, potrebbe derivare più verosimilmente proprio dall'atto del dono: "Donàtoci", abbreviato in "Donaci", con l'aggiunta di "san" per volontà degli amministratori arcivescovili e della devozione degli abitanti. E' significativo il fatto che un altro Comune salentino, San Donato, in provincia di Lecce, sia sorto anch'esso sotto i Normanni, più o meno negli stessi anni. Un'altra ipotesi fa riferimento alla presenza sul territorio di paludi e canneti per far derivare il toponimo dall'indoeuropeo "san o sand" = acqua, e dal greco "donakeus" = canneto. Lo stemma raffigura un albero di palma alla cui base sono tre spighe di grano (sia a destra che a sinistra) e un tralcio di vite. Fu l'Arcivescovo di Brindisi Annibale De Leo a far bonificare il terreno paludoso di San Donaci, dopo aver riottenuto la potestà sul feudo, interrotta a causa delle rivolte degli abitanti per la deludente gestione di alcuni degli amministratori che si erano avvicendati nella seconda metà del sec. XVIII.
Ha una notevole chiesa matrice, dedicata a Maria SS. Assunta, costruita nel 1899 in stile tardo neoclassicista, con campanile a tre piani e cupola. Più antica è la chiesa della Madonna delle Grazie, ora cappella del cimitero, con un'immagine della Vergine dipinta sul muro, databile al XV secolo. In contrada Monticello, sulla strada per Mesagne, è il rudere di San Miserino, uno dei più antichi templi cristiani della provincia, databile tra il VI e l'VIII secolo. Esternamente ha forma quadrangolare, con copertura a cupola; internamente, oltre a una probabile pianta circolare, ha tracce di affreschi e d
- Dettagli
Dal volume "Viaggio in Terra di Brindisi" di Angela Marinazzo
Continua il viaggio nei Comuni della provincia

Panorama di Ostuni - Foto coll. Mogavero-Pennetta
Ma il territorio di Ostuni è stato abitato sin da epoche molto più antiche, come dimostrano l'importante insediamento preistorico nei pressi della cripta di S. Maria d'Agnano, presso l'omonima masseria, in cui sono stati rinvenuti i resti di una giovane donna del paleolitico (circa 24.000 anni fa), e le numerose grotte in cui sono stati rinvenuti reperti ceramici e ossei, gli insediamenti neolitici di Lamaforca e San Biagio, e quello di Morelli che ha restituito reperti dell'età del bronzo. Per merito degli studiosi locali e di amministratori lungimiranti, la città è sede del "Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale".

Ostuni: Borgo antico - Foto coll. Mogavero-Pennetta
Il suo massimo sviluppo urbanistico avvenne nel Rinascimento, allorché all'architettura medievale si affiancarono numerosi edifici riconoscibili per i caratteristici portali con cornici architravate (di cui è un esempio quello della chiesa dello Spirito Santo, del 1637). Il centro cittadino si è spostato da piazza del Moro a piazza Libertà, dov'è il Municipio (nell'ex Convento dei Francescani) e dove fu innalzata, nel 1771, da Giuseppe Greco di Ostuni, la colonna di Sant'Oronzo, alta circa 20 metri, che ha in cima la statua del santo benedicente e, a mezz'altezza e ai quattro angoli, i simulacri dei santi Biagio, Gaetano, Irene e Lucia.
L'attuale fisionomia urbanistica di Ostuni non è molto differente da quella di tre secoli fa, quando la città si sviluppò verso i vicini colli di Casale, Cappuccini, Sant'Antonio, Molino a Vento.
La Cattedrale, dalla bella facciata in stile gotico-romanico, richiese per la costruzione circa mezzo secolo; i lavori, iniziati verso la metà del sec. XV, terminarono nei primi decenni del secolo successivo. L'accesso alla chiesa è dato da tre portali con archi ad ogiva, sui quali si aprono tre rosoni, di cui decoratissimo, con figure degli Apostoli, è quello centrale. Ha un notevole coro ligneo, opera del sec. XVII. In via Pepe è la chiesa dell'Annunziata, ricostruita dai Francescani nel XVIII secolo su una chiesa medievale (S. Maria della Carnara), ad impianto basilicale simile a quello della Cattedrale. Pregevoli i pannelli del coro del 500, scolpiti in legno e laccati, e la volta della cappella del Crocefisso, con le immagini degli Evangelisti e dei dottori della Chiesa, sole testimonianze della chiesa medievale.
Al protettore Sant'Oronzo è dedicato anche un santuario che è sul Monte Morone, in cima alla strada dei colli, ricostruito verso la metà del sec. XVII inglobando una grotta carsica che ha un'immagine della Vergine affrescata su una parete. Oltre il colle di S. Oronzo, in contrada Rialbo, sono i ruderi del santuario di San Biagio, sovrastante un insediamento rupestre medioevale con cripta dedicata al Santo, che vi si sarebbe rifugiato dopo essere stato il vescovo di Sebaste.
Tra Ostuni e Fasano, in contrada Piscomarano, è la più antica architettura di tutta la provincia: il "dolmen (di Montalbano)", letteralmente - dal francese - "tavola di pietra", monumento preistorico funerario o di culto, costituito da grandi e spesse lastre di pietra: due infisse parallelamente nel terreno e un'altra posta sovrastante a copertura; e talvolta un'altra ancora come parete di fondo.
A Villanova, lungo l'antica via Traiana, sulla splendida costa ostunese, vi è il porto con la grande torre del sec. XV, edificata forse in alternativa alle mura fatte costruire dagli Angioini verso la fine del XIII secolo; nei pressi sono stati rinvenuti reperti di età ellenistica e romana.
La Murgia, sulle cui ultime propaggini meridionali si trova Ostuni, significa "sporgenza rocciosa" (dal latino murex = sasso appuntito); costituita in gran parte da calcari cretacei, è nettamente dominata dal 'carsismo': manca perciò di corsi d'acqua e valli. Al loro posto solchi non profondi, a pareti ripide, detti "lame", ed enormi burroni, le "gravine". Nella lama di Rosa Marina, che è una delle più belle del territorio ostunese, in parte occupata dall'omonimo villaggio turistico, sono state rinvenute tracce di un insediamento neolitico e di un insediamento rupestre medioevale. In questi ultimi quarant'anni, Rosa Marina e gli altri eleganti villaggi sorti sulla spiaggia, una delle più pulite dell'Adriatico, hanno fatto di Ostuni e dei Comuni collinari limitrofi una delle zone maggiormente reputate nel Paese e all'estero per il turismo più esigente, poiché uniscono alle bellezze naturali e paesaggistiche (mare, campagna, collina), strutture ricettive di elevata qualità, una cucina sana e genuina, e un grande complesso di beni culturali: storici, artistici e architettonici.
- Dettagli
Dal volume "Viaggio in Terra di Brindisi" di Angela Marinazzo

Castello di Oria - Foto coll. Mogavero-Pennetta
La sua lunga storia, con la fondazione che potrebbe essere avvenuta tra il XVIII e il XV sec. a. C., è documentata dal gran numero di necropoli rinvenute, che continuano a restituire moltissimo materiale archeologico (in parte custodito nel Museo Nazionale di Taranto), risalenti sia al periodo ellenico che a quello messapico. Lo stesso sottosuolo dell'attuale centro urbano è interessato da numerose necropoli, che coprono un vasto periodo, dal X-IX sec. a. C. al III sec. d. C. Tra l'altro, nella città è stato ritrovato un grande invaso artificiale, di epoca messapica, per la raccolta dell'acqua ad usi potabili.
La campagna oritana fu pure apprezzata, per la sua fertilità, dai Romani, che costruirono numerose villa rustiche, e dichiararono Oria prima municipio e poi città federata. Vi fecero passare la più importante delle loro strade, la via Appia, che attraversava la città per oltre un chilometro nella parte settentrionale. Con la caduta dell'Impero romano d'Occidente (476 d. C.), Oria fu devastata da Goti, Greci e Longobardi e più volte saccheggiata dai Saraceni.
Verso la fine del IX secolo, essendo stata Brindisi distrutta dai Saraceni, la cattedra vescovile fu trasferita a Oria. Il primo vescovo là residente, Teodosio, fece costruire una nuova chiesa sull'acròpoli e vi collocò i corpi dei santi Crisanto e Daria, ottenuti da Papa Stefano V nell'anno 886. La chiesa, ora interrata nell'atrio del castello, fu riscoperta nel 1822. E' la prima costruzione in cui sarebbe stato usato da noi il sistema di coprire gli edifici con cupole aggettanti (sporgenti in fuori), ossia a "trullo". Teodosio fece edificare pure una chiesa, scavata nella roccia fuori le mura, in onore di S. Barsanofrio, anacoreta palestinese del VI sec. e patrono di Oria dalla fine del IX sec., l'epoca in cui vi furono traslate le reliquie.
Poco dopo l'anno Mille, Oria passò sotto il dominio dei Normanni che la riedificarono, la cinsero di mura e costruirono una torre quadrata, poi incorporata dal castello fatto edificare da Federico II lo Svevo tra il 1227 e il 1233: un'imponente costruzione a pianta triangolare ai cui vertici sorgono la torre quadrata dello Sperone e le due torri cilindriche del Cavaliere e del Salto, probabili opere degli Angioini. In una delle sale è la collezione archeologica, tra cui monete coniate a Oria, dei conti Martini Carissimo, attuali proprietari del castello. All'inizio del XIV secolo Oria fu annessa al principato di Taranto, divenendo feudo dei principi del Balzo Orsini prima e dei Bonifacio e Borromeo poi, finché fu venduta agli Imperiali, ai quali appartenne sino alla fine del XVIII secolo. Con la morte dell'ultimo degli Imperiali, passò prima al Regno delle due Sicilie e poi al Regno d'Italia.
In cima al paese medievale è la nuova Cattedrale, costruita nel XVIII secolo sui resti della cattedrale romanica. Interessanti sono il settecentesco palazzo del Sedile, o sede del decurionato, a pianta quadrata, e le antiche porte di accesso: Gerocco, Lama, degli Ebrei. Nell'agro oritano, nel Medioevo ricoperto da una grande foresta, merita particolare attenzione la chiesa di S. Maria di Gallana, posta lungo il tracciato dell'antica via Appia, nell'area di una villa rustica romana, divenuta casale nel Medioevo. Presso la masseria Le Salinelle è l'insediamento rupestre con le cripte di S. Maria della Scala e di S. Agostino.
La storia più recente di Oria è strettamente legata a Federico II: in onore del grande imperatore svevo tutta la città partecipa ogni anno, nel secondo fine settimana di agosto, alla rappresentazione del Torneo dei Rioni (Castello, Giudea, Lama e S. Basilio) e del Corteo storico. A testimoniare la grande considerazione di cui godeva Federico II, per la sua saggezza e l'amore innato per la cultura, vi è la bella epigrafe posta sulla sua tomba: "Se la rettitudine, la sensibilità, la grazia delle virtù, la nobiltà potessero resistere alla morte, non sarebbe morto Federico, che qui giace".
- Dettagli
Dal volume "Viaggio in Terra di Brindisi" di Angela Marinazzo

Chiesa Matrice - Foto coll. Pennetta
I Romani popolarono l'agro mesagnese di numerose 'villae rusticae' che dovettero durare fino al tardo Medioevo: ne sono stati rinvenuti i resti nei pressi delle masserie Moreno, Partenio e Campofreddo. Con la fine dell'Impero Romano d'Occidente (476 d. C.) anche Mesagne passò ai Bizantini, che - secondo la tradizione - la cinsero di mura. Nel X secolo fu quasi del tutto distrutta dalle incursioni barbariche; si riprese solo con i Normanni, allorché nel 1062 Roberto il Guiscardo fece costruire l'unico torrione a pianta quadrangolare del castello, che - rinforzato verso il 1430 con due torrette dagli Orsini del Balzo - fu restaurato e ampliato nella prima metà del sec. XVII da Giovanni Antonio Albricci, principe di Mesagne. La costruzione subì profonde modifiche nel 1750 ad opera del marchese Barretta, feudatario dell'epoca, per riparare i danni causati dal terremoto del 20 febbraio 1743: furono allora aperte le otto arcate del primo piano. Adattato a residenza dai marchesi Granafei, ultimi proprietari privati dai quali ha preso il nome, il castello appartiene ora al Comune che lo utilizza come Museo Archeologico Civico, meritevole di una visita, in particolare per la collezione epigrafica e l'interessante corredo funerario di una tomba a semicamera.
Divenne feudo prima degli Svevi e degli Angioini, poi degli Aragonesi che la cinsero di mura. Durante il Risorgimento vi fu istituita la vendita carbonara "I Messapi Liberi", a dimostrazione della sua attiva partecipazione ai moti rivoluzionari.
A settentrione, nei pressi del castello, è Porta Grande, ricostruita nel 1784 dov'era la precedente del XVI secolo, dalla quale si accede al borgo antico. Dalla Porta Nuova, costruita nel 1605 e riedificata nel 1702, si entra invece nel borgo nuovo: è ad unico fornice, ornamentale più che difensiva, con stemmi e iscrizioni sul fastigio. Un'altra Porta, chiamata Piccola, che si trovava a Sud-Ovest, fu demolita nel 1834.
Il palazzo Scalera, costruito verso la metà del sec. XVI, decorato nel piano attico da una lastra su cui è scolpita l'arma della famiglia, ripropone lo schema dell'ingresso fortificato con torre soprastante. Il barocco palazzo del Comune, una volta convento dei Celestini, fu costruito nel XVII secolo.
Nel borgo antico è la Chiesa Matrice dedicata a tutti i Santi, che - costruita tra il 1650 e il 1660 sulle basi di due precedenti chiese dei secc. XIV e XVI - ha un'imponente facciata barocca in càrparo e pietra bianca, spartita in tre ordini di cornicioni e scandita da paraste ioniche e corinzie. Particolari effetti di chiaroscuro sono creati dalle profonde nicchie scavate tra le paraste, con statue di santi. Sul portale principale sono le statue di S. Eleuterio, S. Antea e S. Corebo, protettori della città. Ha l'interno ad unica navata con transetto e coro; sotto il presbiterio è la cripta, che custodisce un pregevole crocefisso ligneo del XVI secolo e due tele che rappresentano la Madonna del Carmine (sec. XVIII) e la Natività di Gian Pietro Zullo (sec. XVII).
La chiesa del Carmine, nei pressi della stazione ferroviaria, è di età romanica, e fu quasi completamente riedificata sulle stesse basi, nel sec. XIV. Tra sovrastrutture del sec. XVI, presenta forme architettoniche tardo-gotiche che ricordano la chiesa di S. Maria del Casale di Brindisi. Vi si accede da un elegante portale, e l'interno conserva ricchi altari barocchi e una tela, restaurata in tempi recenti, della Madonna del Carmelo di Francesco Palvisino, dipinta qualche anno dopo la fondazione del convento, avvenuta nel 1521. Sotto il pavimento sono i resti di un ipogeo con tracce di affreschi e grotte di un antico insediamento anacoretico. Secondo la tradizione, in quel luogo sarebbe stato - nell'alto Medioevo - un santuario dedicato all'arcangelo Michele.
La chiesa dell'Annunziata, che fu costruita una prima volta dai Domenicani dopo il 1548, ha un portale elegantemente scolpito (oggi inserito nella parte esterna del coro della chiesa attuale, iniziata nel 1702), che è uno dei maggiori esempi di arte rinascimentale della provincia: è datato 1555 e firmato da Francesco Bellotto. Nella sua sacrestia è una tela di San Lorenzo da Brindisi, senza l'aureola di santo, probabile opera del pittore leccese Oronzo Tiso. La preziosa pisside del XV secolo, con l'arma della città di Brindisi (le due colonne), proviene dalla distrutta chiesa di S. Maria del Ponte di Brindisi, ove furono i Padri Premonstratensi.

Particolare della chiesa di S.M. in Betlemme
Foto coll. Pennetta
- Dettagli
Continua il viaggio nei Comuni della provincia

Foto Mogavero - Pennetta
Sarebbe stata fondata nell'XI secolo sulle proprietà concesse dai Normanni ai Benedettini di S. Andrea dell'Isola di Brindisi; ma a soli tre chilometri vi è l'area archeologica di Muro Tenente (o Paretone, dai ruderi delle sue imponenti fortificazioni), quasi certamente l'antica Scamnum, che risale all'VIII secolo a. C. e fu abitata sino al VI sec. d. C.; inoltre, nei dintorni sono stati rinvenuti resti di ville prediali romane. La probabile origine del nome è dal latino-italiano "lato", perché il paese - allargatosi unificando i vicini casali - sorge in una vasta campagna.
Dopo la dominazione normanna, sveva, angioina e aragonese, il feudo di Latiano passò nel 1551 ai baroni Francone e da questi alla famiglia Imperiali, marchesi di Francavilla e Oria, che lo detennero sino alla fine del XVIII secolo.
Il castello, ora Palazzo di Città, costruito nel XVII secolo su una preesistente struttura cinquecentesca (cui appartenevano le due torri quadrate, unite in seguito da un corpo di fabbrica), ha sulla facciata un loggiato sormontato da un grande arco, entro il quale è inserito lo stemma degli Imperiali. Furono questi, nel 1724, a trasformare il fortilizio - su probabile disegno dell'architetto Mauro Manieri di Nardò - in elegante residenza, con portale bugnato e finestre riccamente decorate, nella quale raccolsero numerosi quadri di scuola napoletana e veneta del 600 e 700, tra i quali "La Caduta di San Paolo" di Giovanni Papageorgio di Atene, pittore dimorante a Manduria nella metà del sec. XVII (una sua opera, che rappresenta "S. Antonio di Padova", è nella Chiesa degli Angeli di Brindisi, ed altre sono a Oria e Torre).
La Chiesa Matrice, edificata sul finire del sec. XV (o nei primi anni del XVI) sui resti di una chiesa intitolata a S. Michele Arcangelo, è dedicata a Santa Maria della Neve. Più volte rimaneggiata, ha ora una sobria facciata scandita da lesene. Nella chiesa del SS. Crocefisso si venera un crocefisso ligneo del 600. Fuori del centro abitato è il Santuario della Madonna di Cotrino, costruito nell'ultimo decennio a ridosso di una cappella secentesca che conserva, più volte restaurato, un affresco con l'immagine miracolosa della Vergine (una contadina della Basilicata fu guarita in quel luogo da una grave malattia). Tra Latiano e San Vito è una chiesa rurale dedicata a Santa Maria della Selva. A pochi chilometri, nei pressi della masseria Grottole, è la cripta di S. Angelo con tracce di affreschi databili al XIII secolo: s'intravedono una Madonna con Bambino, S. Michele Arcangelo e S. Giovanni.
Dal 1974 Latiano dispone di un interessante Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari, con la ricostruzione - ricca di innumerevoli oggetti d'epoca - dell'ambiente casalingo e delle attività agricole e artigianali.